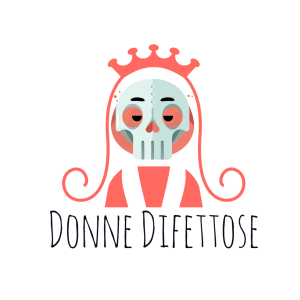di Elena Ciurli
La protagonista di questo appuntamento di Interviste Difettose è l’autrice, formatrice e documentarista Francesca Rosati Freeman, che ci porterà in una dimensione molto particolare: il mondo delle donne.
Francesca ha visitato più volte il paese dei Moso e ha fatto una ricerca sul campo inerente alla cultura e ai costumi di questa società matriarcale per più di dieci anni.
Nel 2010 ha pubblicato Benvenuti nel paese delle donne (XL Edizioni, Roma) e nel 2015 ha pubblicato Sur les rives du lac Mère (Ed. Tensing, Paris), che è una traduzione del precedente, ma con aggiornamenti vari. Ha realizzato con Pio d’Emilia il documentario Nu Guo. Nel Nome della Madre, selezionato in diversi festival e premiato dal Pubblico al Festival International du Cinéma d’Asie de Vesoul, Francia, 2015.
Le abbiamo fatto alcune domande per riuscire a mettere in luce questo affascinante pezzo di mondo al femminile.

Quando nasce il tuo interesse per l’etnia Moso?
E’ nel 2004 che ho scoperto l’esistenza dell’etnia Moso. Nel campo lavorativo mi sono occupata tra l’altro anche di minoranze etniche, ma quella dei Moso mi era sconosciuta.
Girovagando per i corridoi dell’aeroporto di Roma, in attesa del volo che mi riportasse a casa, ho trovato in un chiosco di giornali, sotto una pila di libri disposti in modo disordinato, un libro il cui titolo attirò subito la mia attenzione: Il paese delle Donne di Erche Namu e Christine Matthieu, la prima è una donna dell’etnia Moso e l’altra un’antropologa. La lettura del libro mi affascinò talmente che dopo un anno di preparazione, di raccolta di informazioni e documentazioni, peraltro scarse, partii per visitare questa etnia, nel Sud-Ovest della Cina, ai confini del Tibet, sulle pendici dell’Himalaia a 2700m. di altitudine.
Dopo il primo viaggio ne sono seguiti tanti altri. Ho soggiornato presso le famiglie locali e svolto assieme ad esse le attività quotidiane, ciò che mi ha permesso di osservare e di capire in profondità la loro cultura e organizzazione familiare e sociale. Ho dovuto liberarmi dei parametri occidentali e dell’eurocentrismo tipico nostro per capire certi concetti come la famiglia, il matrimonio, la consanguineità etc. che nelle società patriarcali sono considerati universali mentre presso l’etnia Moso questi concetti assumono significati così diversi tali da capovolgere completamente il nostro sistema di valori.
Qual è stato l’elemento culturale e organizzativo che ti ha maggiormente colpito?
L’assenza di violenza, l’assenza di matrimonio e di coabitazione delle coppie, la stigmatizzazione della gelosia, l’assenza della nozione di proprietà privata per le persone e le cose materiali, la pratica del consenso, l’educazione non di genere, ma soprattutto la valorizzazione delle donne con le madri a guida della famiglia e la pratica dei valori del principio materno hanno suscitato il mio interesse per questa etnia.
L’aver trovato in questo posto così sperduto una società ugualitaria dove non esiste un sesso considerato superiore all’altro, dove non esiste un’attività considerata superiore o inferiore in base al sesso mi ha stimolato a fare ulteriori ricerche per capire meglio quali sono le fondamenta di una società che permette a circa quarantamila persone di vivere così pacificamente e armoniosamente, dove tutti, donne, uomini, giovani, anziani e bambini hanno ciascuno il loro posto nella famiglia e nella società e sono soddisfatti di quello che hanno.
Anche se il ruolo di guida della famiglia è affidato alla dabu, la donna più anziana, ma anche la più saggia e imparziale, non c’è nessuna discriminazione, nessuna oppressione o repressione sul sesso opposto e gli uomini apprezzano il ruolo della dabu e delle donne in genere senza rischiare di perdere la propria virilità.

Spesso si guarda alle società matriarcali come società dove comandano le donne. Non c’è niente di più errato. L’opinione corrente definisce il matriarcato come l’equivalente femminile del patriarcato, ma secondo la filosofa e storica tedesca Heide Goettner-Abendroth, studiosa di società matriarcali da più di 30 anni, bisognerebbe pensare alla parola arké non come dominio ma come inizio, origine, associando la parola mater a colei che genera la vita e non a colei che la domina. Intendere il matriarcato come dominio delle madri darebbe ingiustamente una connotazione negativa a un tipo di società pacifica diminuendone il valore. Si sa come il dominio generi la guerra e non la pace.
Pensi che l’Europa e l’Occidente in generale potranno essere mai pronti per un tipo di società matriarcale in qualche modo simile a quella Moso?
Penso che la cultura di un popolo non possa essere trasferita tale e quale da un luogo all’altro, ma ci sono dei valori cui potremmo senz’altro ispirarci. Per esempio la pratica del consenso potrebbe essere integrata nella nostra società. I Moso discutono su qualsiasi problema, familiare o sociale che sia e si pone un termine alla discussione quando tutti sono soddisfatti del risultato finale, altrimenti si continua a discutere fino a quando si arriva a un accordo. Questa è una pratica di prevenzione dei conflitti che si può realizzare a tutti i livelli : in famiglia come nei gruppi, nelle associazioni, in politica…
Dare più valore al femminile potrebbe avere come conseguenza positiva quella di equilibrare i generi. Una educazione non di genere e non discriminante sarebbe possibile applicarla fin dalla più tenera età.
Non penso però che siamo pronti a cambiare la nostra struttura familiare patrilineare in matrilineare o l‘economia di mercato in economia solidale, oppure eliminare il matrimonio e la convivenza della coppia. Sarebbe bello vivere il proprio amore fuori dai condizionamenti del matrimonio e separato dalla vita familiare e dai beni patrimoniali. Lontano dalla quotidianità lo si potrebbe vivere in tutta la sua purezza e bellezza spirituale. Tutto questo comporterebbe il cambiamento del paradigma della nostra società, ma penso che siamo lontani anni luce prima che si possa attuare una simile rivoluzione socio-culturale.

Cosa significa lottare per le donne oggi? Cosa è cambiato rispetto al passato?
Preferirei che questa domanda la rivolgeste alla scrittrice e femminista storica Luciana Percovich che ha recentemente pubblicato il libro «Verso il luogo delle origini» dove tratta appunto questo argomento.
Per quanto riguarda le donne Moso posso solo dire che non hanno bisogno di lottare per la parità dei diritti, non hanno bisogno di essere femministe perché vivono in una società ugualitaria e non devono lottare quotidianamente contro il patriarcato, la discriminazione e la violenza.
Inoltre esse sono le dispensatrici di un sapere millenario legato alla terra e tramandano questo sapere di generazione in generazione, un sapere che la scienza moderna, maschilista e patriarcale altrove ha condannato a morte.
Una lotta che le donne e gli uomini Moso dovrebbero condurre sarebbe quella di non lasciarsi sopraffare dalle influenze esterne che vorrebbero uniformare i loro costumi a quelli del resto del paese, purtroppo il cambiamento è già in atto.
 Prossimi eventi i progetti in programma?
Prossimi eventi i progetti in programma?
Ho fatto già più di un centinaio di presentazioni del mio libro «Benvenuti nel Paese delle Donne» tradotto in francese col titolo : «Sur les Rives du Lac Mère» e del film-documentario realizzato con Pio d’Emilia : «Nu Guo. Nel Nome della Madre» premiato al festival del cinema asiatico di Vesoul, Francia nel febbraio 2015. Recentemente ho anche realizzato un cortometraggio di 25 mn : Gammu, Montagna, Dea, Madre che mette in evidenza la relazione fra le donne, la Natura e la divinità della montagna sacra della popolazione Moso.
Continuerò a presentare queste mie opere e a diffonderle per fare conoscere questa etnia a più persone possibili.
In programma: la traduzione del mio libro in inglese e spero di ritornare a visitare le famiglie Moso al più presto.
Grazie Francesca per averci mostrato con rispetto e passione questo straordinario popolo.